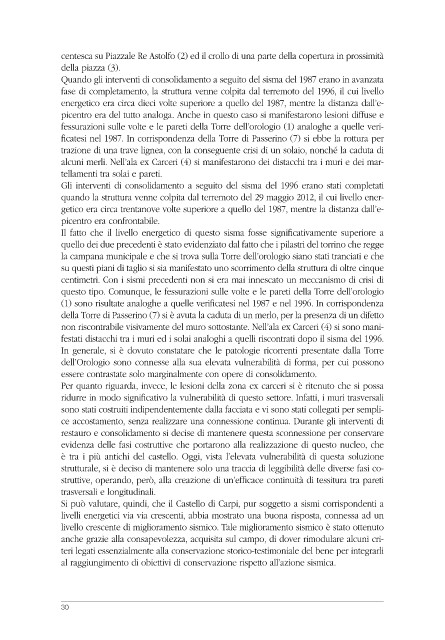Page 32 - Unimore e il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna
P. 32
centesca su Piazzale Re Astolfo (2) ed il crollo di una parte della copertura in prossimità
della piazza (3).
Quando gli interventi di consolidamento a seguito del sisma del 1987 erano in avanzata
fase di completamento, la struttura venne colpita dal terremoto del 1996, il cui livello
energetico era circa dieci volte superiore a quello del 1987, mentre la distanza dall’e-
picentro era del tutto analoga. Anche in questo caso si manifestarono lesioni diffuse e
fessurazioni sulle volte e le pareti della Torre dell’orologio (1) analoghe a quelle veri-
ficatesi nel 1987. In corrispondenza della Torre di Passerino (7) si ebbe la rottura per
trazione di una trave lignea, con la conseguente crisi di un solaio, nonché la caduta di
alcuni merli. Nell’ala ex Carceri (4) si manifestarono dei distacchi tra i muri e dei mar-
tellamenti tra solai e pareti.
Gli interventi di consolidamento a seguito del sisma del 1996 erano stati completati
quando la struttura venne colpita dal terremoto del 29 maggio 2012, il cui livello ener-
getico era circa trentanove volte superiore a quello del 1987, mentre la distanza dall’e-
picentro era confrontabile.
Il fatto che il livello energetico di questo sisma fosse significativamente superiore a
quello dei due precedenti è stato evidenziato dal fatto che i pilastri del torrino che regge
la campana municipale e che si trova sulla Torre dell’orologio siano stati tranciati e che
su questi piani di taglio si sia manifestato uno scorrimento della struttura di oltre cinque
centimetri. Con i sismi precedenti non si era mai innescato un meccanismo di crisi di
questo tipo. Comunque, le fessurazioni sulle volte e le pareti della Torre dell’orologio
(1) sono risultate analoghe a quelle verificatesi nel 1987 e nel 1996. In corrispondenza
della Torre di Passerino (7) si è avuta la caduta di un merlo, per la presenza di un difetto
non riscontrabile visivamente del muro sottostante. Nell’ala ex Carceri (4) si sono mani-
festati distacchi tra i muri ed i solai analoghi a quelli riscontrati dopo il sisma del 1996.
In generale, si è dovuto constatare che le patologie ricorrenti presentate dalla Torre
dell’Orologio sono connesse alla sua elevata vulnerabilità di forma, per cui possono
essere contrastate solo marginalmente con opere di consolidamento.
Per quanto riguarda, invece, le lesioni della zona ex carceri si è ritenuto che si possa
ridurre in modo significativo la vulnerabilità di questo settore. Infatti, i muri trasversali
sono stati costruiti indipendentemente dalla facciata e vi sono stati collegati per sempli-
ce accostamento, senza realizzare una connessione continua. Durante gli interventi di
restauro e consolidamento si decise di mantenere questa sconnessione per conservare
evidenza delle fasi costruttive che portarono alla realizzazione di questo nucleo, che
è tra i più antichi del castello. Oggi, vista l’elevata vulnerabilità di questa soluzione
strutturale, si è deciso di mantenere solo una traccia di leggibilità delle diverse fasi co-
struttive, operando, però, alla creazione di un’efficace continuità di tessitura tra pareti
trasversali e longitudinali.
Si può valutare, quindi, che il Castello di Carpi, pur soggetto a sismi corrispondenti a
livelli energetici via via crescenti, abbia mostrato una buona risposta, connessa ad un
livello crescente di miglioramento sismico. Tale miglioramento sismico è stato ottenuto
anche grazie alla consapevolezza, acquisita sul campo, di dover rimodulare alcuni cri-
teri legati essenzialmente alla conservazione storico-testimoniale del bene per integrarli
al raggiungimento di obiettivi di conservazione rispetto all’azione sismica.
30